Sull’Unità 23 ottobre 2001 c’è una intervista a Vittorio Foa, sindacalista, storica personalità della sinistra, che vale la pena di rileggere per i concetti che Foa espone sulla questione del pacifismo. Il contesto dell’intervista è la risposta da dare al terrorismo che aveva appena assalito gli USA l’11 settembre. Le parole di Foa dovrebbero a mio parere cercare di scalfire le categorie di ‘pacifisti’ e ‘guerrrafondai’ in cui spesso si banalizza la questione, (Giuro: non citerò l’abusato motto romano “Si vis pacem para bellum”.)
Lei dice che non bisogna aver dubbi sulla necessità di far la guerra al terrorismo. Questo però la mette in contrasto con un grande movimento,soprattutto centinaia di migliaia di ragazzi, che inneggiano al pacifismoe, secondo tutti gli osservatori, costituiscono una straordinaria risorsa positiva per il paese.
È una domanda molto seria. Un problema che non sopporta superficialità. Voglio dire, anzi confessare, che nel periodo della mia formazione politica, negli anni Venti e Trenta, il pacifismo che si presentava come sinistra e come socialista, era da noi giovani che lottavamo contro il fascismo considerato intollerabile. Era il nemico principale che voleva disarmare la democrazia di fronte al nazismo, che non voleva che le potenze democratiche intervenissero in Spagna o in Etiopia o in altri punti del mondo dove i nazifascismi stavano conquistando il potere. Tutta la sinistra considerava i pacifisti come il peggior nemico interno. Poi venne la guerra e nella Resistenza non c’è mai stata un’ ombra di pacifismo. La Resistenza è stata organicamente antipacifista.Dopo la guerra il movimento pacifista si riaffacciò.
Sì, ma a parte la sparuta minoraza dei La Pira e Capitini, era figlio della guerra fredda. Un movimento molto ambiguo. La pace era un trucco per poter sostenere le ragioni dell’Unione sovietica nella guerra fredda. Poi finisce la guerra fredda. Appunto. E inizia una situazione radicalmente nuova, assolutamente priva di contatti con le esperienze pacifiste del secolo scorso. Direi che si realizza, anche sul piano culturale, un generale declino del senso della collettività. C’è il ritorno dell’individuo, il bisogno di non dipendere sempre dagli altri e di vedere in se stessi un soggetto del proprio futuro. Questo bisogno si manifesta in varie forme. Una di queste forme è presente nei giovani e nei giovanissimi. Loro non hanno mai vissuto la violenza come noi uomini del Novecento. Non hanno capito che la violenza è intrinseca nel modo di vivere e che il modo di vivere consiste nel combattere contro la violenza, nel far finire le guerre. I giovani che non hanno vissuto tutto questo hanno bisogno, giustamente, di cielo pulito.Sembra un’espressione poetica. Mi faccia capire meglio.
Un cielo pulito, senza ordigni mortali, non è una espressione poetica. Per i giovani cielo pulito è dare spazio ad infinite possibilità umane. Uno spazio di libertà: il cielo pulito è lo spazio della libertà. Io rispetto queste cose, ma fanno di una visione religiosa e certamente pre politica. C’è nei giovani che vivono questa esperienza un bisogno di identificazione in valori trascendenti. C’è poi un aspetto meno nobile del pacifismo.Quale?
Il consumismo. Non rompetemi l’anima coi vostri principi e lasciatemi consumare in pace. Questo c’è nel costume. Questa doppia forma di individualismo pacifista, frutto della cultura di fine ventesimo secolo, scolorisce il collettivo. Dipendere dagli altri diventa sgradevole. Ecco, a questo individualismo oggi va data con chiarezza e senza vergogna una risposta culturale: ci vuole la politica per salvare la collettività, per sopravvivere a un pericolo mortale che incombe, per rivedere e rifare il mondo attorno a noi.Lei ha individuato due forme di pacifismo: quello nobile e quello consumista. E i Verdi? Bertinotti e Cossutta?
Non vorrei dire cose severe che possono essere ingiuste. Ma certe volte penso che certe manifestazioni pacifiste non sono risposte ai problemi del mondo ma a piccoli problemi d’immagine e del proprio gruppo, il bisogno di fornire una certa immagine ad amici e seguaci. Non solo tra Verdi e comunisti ma anche tra i miei amici Ds certe richieste di sospendere le operazioni in Afghanistan, hanno motivi più complessi. Non sono legati alla lotta contro il terrorismo ma ad altri problemi. Lo trovo molto pericoloso sul piano etico. Perché come molte altre volte il pacifismo tende a cancellare il motivo del conflitto.Lei sostiene che il nostro paese ha avuto comprensione dell’Islam. Le posizioni del governo come le ha percepite?
Come quasi tutto quello che viene da Berlusconi: una stupidità e le chiedo scusa per la schiettezza. Non vedo in Berlusconi, lo dico con franchezza, un populismo che annuncia la reazione. Ma qualcosa di peggio. La politica civile del governo non è solo sbagliata ma infame. Vorrei lo scrivesse: non c’è solo la ricerca dell’impunità per un ceto politico, un personaggio o un’azienda. C’è un invito alla corruzione. Una richiesta al popolo a corrompersi e a corrompere. Una diseducazione profonda a cui spero che gli italiani sappiano rispondere. Quando dico queste cose chiedo anche che su alcuni problemi alti che riguardano la politica del mondo ci sia una impostazione bipartisan. Ho sentito dire ad alcuni miei cari compagni: sono all’opposizione e quindi devo votare contro. No. Sei all’opposizione e voti con la tua testa. Berlusconi non è capace di una politica bipartisan? Peggio per lui. L’Ulivo e la sinistra devono comunque perseguirla. Si sarebbe dovuto cercare in Parlamento un voto unitario sul terrorismo? Io credo di sì. Perché si ha la sensazione che l’Italia conti meno in Europa? Intanto, perché il governo non crede nell’Europa. La Lega, altre forze di maggioranza e anche pezzi di Forza Italia non credono nell’Europa. L’opposizione deve sollecitare invece una presenza attiva nell’Europa, correndo i rischi che ci sono. I contrasti ci saranno: sulla struttura della Commissione, l’allargamento ad Est, lotta al terrorismo. Su tutto questo dobbiamo essere finalmente europei. Nel modo più esplicito dobbiamo rivendicare l’Europa. Si profila una crisi economica in tutto il mondo. Dobbiamo chiedere all’Europa di non rilanciare i consumi come prima, ma di dare un altro senso alla nostra struttura, rivalutando un intervento pubblico che sia sollecitazione e incentivo.

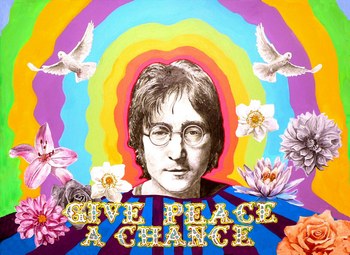




















Commenti recenti